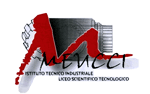
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - Fax 0585 251012
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5
Email: msis01800l@istruzione.it - msis01800l@pec.istruzione.it
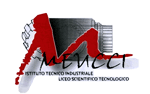 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) |
 |
IIS "ANTONIO MEUCCI"
- Piano di Studi del corso MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA articolazione MECCANICA E MECCATRONICA
- Presentazione sintetica della classe
- Obiettivi generali raggiunti
- Attività svolte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi socio-affettivi, di comportamento e motivazione
- Attività svolte di recupero
- Attività svolte di approfondimento
- Attività integrative realizzate
- Elenco progetti realizzati
- Attività di Educazione Civica
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e attività del Piano di Orientamento
- Criteri di valutazione adottati
- Criteri di valutazione delle singole discipline
- Modalità di valutazione
- Indicazioni, modalità e criteri per gli strumenti di verifica e valutazione
- Simulazione della prima prova
- Simulazione della seconda prova
- Simulazione della colloquio
- Sottoscrizione del documento
1. Piano di studi del corso MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA articolazione MECCANICA E MECCATRONICA
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | ||
|---|---|---|---|
| Terza | Quarta | Quinta | |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | 0 |
| Meccanica, macchine ed energia | 3(1) | 4(2) | 4(1) |
| Sistemi e automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | 4(2) | 3(2) | 4(2) |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
| Robotica | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 |
Nota: le ore tra parentesi sono di laboratorio.
2. Presentazione sintetica della classe
2.1 Storia del triennio
Nell'a.s. 2022/23 alla classe 4AMEC sono stati uniti 8 alunni provenienti dalla 3BMEC dell'anno precedente e la classe è risultata composta da 22 alunni di cui uno con certificazione legge 104/1992
Nello scrutinio di giugno 5 alunni sono stati ammessi alla classe successiva,3 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva,8 alunni hanno avuto il giudizio sospeso, di cui 3 non sono stati ammessi alla classe successiva nello scrutinio di agosto.
Attualmente la classe 5AMEC di 12 alunni, di cui uno con certificazione legge 104/1992, è stata articolata con i restanti 2alunni della 4AGR dell'anno precedente nella 5ART composta da 14 alunni in totale.
2.2 Continuità didattica nel triennio
| Classe | Lingua e letteratura Italiana | Storia | Lingua Inglese | Matematica | Complementi di matematica | Meccanica, macchine ed energia | Sistemi e automazione | Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | Robotica | Scienze motorie e sportive | Religione Cattolica |
| 3A | A1 | A1 | A1 | A1 | A | A | A | A1 | A | A1 | A | A |
| 3B | A2 | A2 | A2 | A2 | A | A | A | A2 | A | B | A | A |
| 4 | B | B | B | B | A | A | A | A2 | A | B | A | B |
| 5 | A2 | A2 | A2 | C | A | B | A1 | A | B | A | B |
Nota: A per il primo docente, B per l'eventuale secondo, C per l'eventuale terzo,D per l'eventuale quarto, S per diversi docenti per periodi significativi nel corso dello stesso anno
2.3 Situazione di partenza all'inizio del corrente anno scolastico
Per quanto riguarda la situazione relativa al comportamento gli studenti risultano corretti e rispettosi nei rapporti interpersonali.
Tutti gli studenti,nel complesso, mostrano interesse per le attività didattiche e le iniziative della scuola;la partecipazione è abbastanza continua per alcuni, altri necessitano ancora di richiami e sollecitazioni. Lo studente con certificazione segue le attività avvalendosi in modo costruttivo del supporto degli insegnanti di sostegno.
In relazione alle competenze trasversali gli studenti evidenziano una positiva disponibilità ad interagire e collaborare; in generale ,devono ancora consolidare, in alcuni casi acquisire, un metodo di lavoro completamente autonomo.
Per quanto concerne l'impegno e la motivazione risulta ancora inadeguato il lavoro domestico; lo studio, in generale, è limitato all'imminenza della verifica e lo svogimento di quanto assegnato è strettamente finalizzato al voto.
2.4 Caratteristiche specifiche del percorso curricolare e/o della sperimentazione
nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti,
nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi
meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia è in grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica,
elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; intervenire, relativamente alle
tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il
consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; agire autonomamente, nell’ambito delle
normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; pianificare la produzione e la certificazione
degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e
manuali d’uso. Prosecuzione degli studi: al termine dei 5 anni naturalmente è possibile proseguire gli studi con corsi di
istruzione tecnica superiore e a livello universitario.
Attualmente nel nostro Istituto è attiva l'articolazione MECCANICA E MECCATRONICA. A partire dall'anno scolastico
2018-2019 per l'articolazione MECCANICA E MECCATRONICA, Il Collegio dei Docenti in data 9.11.17 ha deliberato il
piano orario descritto precedentemente, con l'inserimento della disciplina Robotica.
3. Obiettivi generali raggiunti
3.1 Obiettivi didattici
- saper far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità che sono alla base della vita sociale;
- utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti della partecipazione alla vita scolastica messi a disposizione;
- gestire le situazione di conflitto mediante le capacità di mediare e di negoziare per creare spazi di condivisione;
- acquisire le conoscenze fondamentali di tutte le discipline comprese nel curricolo sviluppando la capacità di interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi linguaggi e fonti d’informazione;
- utilizzare efficacemente le capacità di studio, di riflessione, di corretta applicazione e rielaborazione delle conoscenze anche mediante la scelta di strategie adatte ai propri stili di apprendimento e di studio;
- conoscere e apprezzare i prodotti artistici, culturali, scientifici e tecnologici nelle loro dimensioni storiche e sociali e valutare il loro ruolo nella società.
- utilizzare la capacità di valutazione delle situazioni problematiche mediante le strategie del problem posing (analisi e riflessione sulla situazione problematica, concettualizzazione e esposizione del problema);
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
- prendere consapevolezza dell’opportunità di controllare attendibilità e validità dei risultati ottenuti nei vari processi lavorativi o nelle procedure individuate per la soluzione di problemi, acquisire capacità di giudizio sulla utilità di strumenti e mezzi di lavoro e sulla significatività dei risultati ottenuti, documentare il lavoro svolto;
- condurre in maniera autonoma esperienze di laboratorio, elaborare e realizzare semplici progetti tipici delle discipline tecnico - scientifiche;
- acquisire la capacità di presentare autonomamente argomenti di studio e di interesse personale usando anche strumenti multimediali;
- potenziare la conoscenza delle caratteristiche e della natura del mondo del lavoro anche mediante esperienze dirette e integrate con il curricolo scolastico;
- acquisire consapevolezza delle modalità e delle difficoltà relative alle scelte da compiere al termine del percorso di studio secondario;
- acquisire la conoscenza delle caratteristiche dell’offerta proveniente dal mondo del lavoro e le opportunità di formazione presenti sul territorio al fine di compiere scelte consapevoli al termine del percorso scolastico;
- acquisire gli strumenti linguistici per poter studiare una disciplina utilizzando una lingua straniera.
3.2 Obiettivi specifici
- Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
- Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
- Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
- Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura
- Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
- Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.
4. Attività svolte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi socio-affettivi, di comportamento e motivazione
- motivare gli allievi al rispetto delle regole di Istituto mediante dialogo, stimolandoli anche alla trasmissione di dette regole ai compagni meno corretti;
- sollecitare gli studenti a rispettare la puntualità delle consegne, ad organizzare il proprio lavoro con accuratezza e razionalità, a partecipare attivamente alle lezioni;
- valutare con attenzione la regolarità della frequenza e il numero di permessi per ingressi/uscite fuori orario degli studenti;
- valutare il comportamento degli studenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente scolastico, il rispetto interpersonale della salute dei compagni, la tolleranza, la solidarietà;
- proporre lavori di gruppo per consolidare la collaborazione reciproca;
- promuovere esperienze che aiutassero gli alunni a fare propri ed a trasmettere i valori della nostra Costituzione.
5. Attività svolte di recupero
- sono stati predisposti momenti di potenziamento e recupero in classe durante le lezioni curricolari;
- sono stati stimolati gli alunni a frequentare le attività di sportello/studio pomeridiano attivate dalla scuola;
- nello svolgimento dei compiti a casa, gli alunni hanno potuto interagire con i docenti attraverso la Google Workspace dell'Istituto.
6. Attività svolte di approfondimento
A) APPROFONDIMENTO
Gli alunni sono stati stimolati all'approfondimento di alcuni argomenti attraverso letture mirate, visione di documentari storici e/o film, esercizi.
B) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
I docenti delle materie tecnologiche hanno sviluppato attività nei laboratori a consolidamento delle nozioni teoriche.
7. Attività integrative realizzate
partecipazione a conferenze programmate dall'Istituto (ambito storico-letterario, tecnico-scientifico ecc.);
partecipazione della classe ai progetti d'Istituto ed alle attività di orientamento;
progetto PCTO;
viaggio d'istruzione: Trieste, Gorizia e Lubiana
Per quanto riguarda le attività alternative all'IRC il CdC ha proposto lo studio autonomo
8. Elenco progetti realizzati
"La legalità come vantaggio" educare al rispetto delle regole per la costruzione del bene comune
Memoria e memorie: IMI – Un’altra Resistenza
Biblioteca scolastica
Reading Italo Calvino
Reading Primo Levi
Cerimonia di consegna dei diplomi
Orientamento in ingresso
9. Attività di Educazione Civica
10. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e attività del Piano di Orientamento
11. Criteri di valutazione adottati
I criteri di giudizio per l’attribuzione del voto di condotta comprendono la maturazione e crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo oggetto di valutazione ed eventuali singoli episodi che hanno dato origine a sanzioni disciplinari. In particolare le voci relative alla valutazione del comportamento sono:
- SOCIALIZZAZIONE E RELAZIONI CON I COMPAGNI
- RISPETTO DELLE REGOLE, DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE COSE
- GRADO DI COLLABORAZIONE CON DOCENTI E COMPAGNI 4
- RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE
- EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI
- La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico.
- La valutazione del secondo quadrimestre deve tenere conto delle modalità cn cui lo studente ha reagito ad eventuali richiami o sanzioni disciplinari irrogate nel primo quadrimestre al fine di prendere in considerazione nella valutazione finale i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
Lo studente ha contravvenuto alle regole, è stato sospeso per un periodo significativo dalle lezioni a causa di comportamenti gravi che violano lo Statuto Studenti nei due ambiti seguenti:
- responsabilità rispetto all’articolo 4, commi 9 e 9bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti per reati che violano la dignità e il rispetto della persona o costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone e/o allarme sociale ;
- responsabilità rispetto all’articolo 3 commi 1, 2 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti che comportano inosservanza dei propri doveri di studenti (frequenza regolare, impegno assiduo di studio, rispetto verso le persone e le cose ).
L’attribuzione del voto da 1 a 5 è proporzionale alla gravità dei comportamenti e alle sanzioni irrogate.
VOTO 6
Lo studente contravviene a norme di partecipazione corretta alla vita della comunità scolastica; ha bisogno di un continuo intervento di richiamo verbale e/o scritto e solo grazie ad esso dimostra di aver conseguito qualche miglioramento.
Sono inoltre da prendere in considerazione eventuali sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalle lezioni, la presenza di ritardi non motivati e/o non giustificati, frequenza non assidua con assenze non dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti pur in presenza di giustificazioni regolari, giustificazioni non regolari.
VOTO 7
Lo studente applica parzialmente o in modo discontinuo le regole; ha bisogno di richiami e solo grazie ad essi sono constatabili miglioramenti
Sono tollerati nel periodo oggetto di valutazione non più di un avvertimento scritto o non più di due note disciplinari.
Sono inoltre da prendere in considerazione eventuale presenza di ritardi non motivati anche se giustificati, frequenza non sempre assidua con assenze non dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti pur in presenza di giustificazioni regolari.
VOTO 8
Lo studente dimostra di avere assimilato regole e valori fondamentali di rispetto della persona e osserva le fondamentali regole della vita scolastica anche se in qualche caso ha avuto bisogno di essere richiamato.
La frequenza è regolare (o le assenze sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti).
I ritardi possono essere sporadici e comunque giustificati. È tollerata nel periodo oggetto di valutazione non più di un nota disciplinare.
VOTO 9
Lo studente dimostra di avere assimilato regole e valori fondamentali di rispetto della persona e osserva le regole della vita scolastica senza bisogno di richiami.
Partecipa alla vita scolastica. Non devono essere state irrogate sanzioni disciplinari nel periodo oggetto di valutazione.La frequenza è assidua (o le assenze sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti).
VOTO 10
Lo studente dimostra di aver assimilato il valore della convivenza civile poiché esprime rispetto e solidarietà nei rapporti interpersonali e partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola.
Rispetta e condivide le regole individuate nel Regolamento di Istituto Non devono essere state irrogate sanzioni disciplinari nel periodo oggetto di valutazione o nel corso dell’anno scolastico.
La frequenza è assidua (o le assenze sono dovute a motivi che possono comportare l’applicazioni delle deroghe previste dal collegio dei docenti)
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE
I criteri che seguono sono:
- necessari per fornire punti di riferimento omogenei per tutti i consigli di classe;
- vincolanti per tutti i Consigli di classe in quanto l’individuazione di tali criteri costituisce, in base alla normativa vigente, competenza specifica del Collegio dei docenti, pur rimanendo il processo di valutazione dei singoli alunni un atto specifico dei singoli Consigli esente da automatismi decisionali.
Ogni decisione del Consiglio di classe dovrà essere motivata. L’ammissione all’esame finale del secondo ciclo è all’unanimità nel caso in cui le proposte di voto siano tutte sufficienti.
Nel caso in cui invece tra le proposte di voto dei docenti sia presente anche una sola insufficienza, si propone la votazione a maggioranza per l&rsquoalunno al fine di decidere la non ammissione quando le numerose insufficienze (maggiori di tre) evidenzino lacune gravi in un numero elevato di discipline o quando, pur in presenza di insufficienze non numerose, queste siano gravi e riguardino le discipline di indirizzo.
Il credito scolastico è assegnato ad ogni studente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente ( DPR 323/1998 art 11) e dei criteri approvati dal Collegio docenti del 19 Dicembre 2013 secondo la seguente proposta:
Dopo aver calcolato la media dei voti compreso il voto di condotta e individuata la fascia corrispondente , si assegna:
il massimo della fascia se allo studente vengono riconosciuti almeno tre dei seguenti indicatori:
- media dei voti pari o superiore a 0,5 ;
- consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la partecipazione corretta e propositiva al dialogo educativo; deliberato a maggioranza dal C.d.C.
- assiduità nella frequenza: assenze inferiori al 12% del monte ore totale di assenze, escluse le assenze previste per le deroghe;
- attestati di partecipazione ai progetti proposti dalla scuola, attività di alternanza scuola – lavoro e di orientamento rilasciati nell’anno scolastico di riferimento;
- attestati rilasciati da enti esterni alla scuola legati ad attività svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all&rsquoambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34) rilasciati nell’anno scolastico di riferimento
- se lo studente non presenta la situazione precedente;
- se il giudizio dello studente è stato sospeso, a meno che non siano presenti almeno tre indicatori e abbia ottenuto valutazioni pari o superiori a 7 nelle prove di Settembre.
- Se lo studente ha beneficiato per essere ammesso alla classe successiva, all’esame finale del secondo ciclo del voto o per la sospensione del giudizio del voto di consiglio per modificare anche una sola proposta di voto, viene attribuito il minimo della fascia.
In relazione alle deroghe motivate e straordinarie previste dall’ART 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, relative ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, il Collegio dei Docenti, con delibera n° 19 del 13 Novembre 2013, ha deciso che tali deroghe possano essere concesse solo per assenze legate a motivi di salute o personali con le seguenti caratteristiche:
- assenze continuative e prolungate (non inferiore a 10 giorni per ciascuna assenza) determinate da problemi di salute documentati mediante certificato medico;
- assenze ripetute (minimo 10 giorni) legate a patologie croniche, a terapie e/o cure programmate di cui la scuola è stata debitamente informata mediante certificato medico fin dall’inizio dell’anno scolastico o fin dall’inizio delle assenze o dalla diagnosi legate alla patologia (in tal caso sarà cura della famiglia o dello studente indicare nella giustificazione di ciascun giorno di assenza la motivazione in modo tale che sia riconducibile alla patologia);
- donazioni di sangue;
- assenze prolungate (minimo 15 giorni) per gravi motivi personali o familiari documentati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione fin dal momento in cui è iniziata l’assenza;
- assenza per partecipazione ad attività sportive agonistiche o per allenamenti presso società sportive agonistiche in preparazione di gare ufficiali documentati dalla società sportiva fin dal momento in cui è tale attività è iniziata;
- assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- per gli studenti lavoratori, assenze dovute allo svolgimento di attività lavorative documentate con dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione per i lavoratori autonomi fin dal momento in cui è tale attività è iniziata.
Le deroghe possono essere concesse a condizione che il consiglio di classe abbia la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi valutati rispetto a quelli previsti per la promozione all’anno successivo o all’ammissione all’esame finale del secondo ciclo.
12. Criteri di valutazione delle singole discipline
2 - IMPEGNO, INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI E ALLE ATTIVITÀ EVIDENZIATI ATTRAVERSO LA PUNTUALITÀ E LA COSTANZA NELL’ESECUZIONE DEI COMPITI E DELLE CONSEGNE, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI COME LAVORO DOMESTICO.
3 – AUTONOMIA E PADRONANZA DEL METODO STUDIO EVIDENZIATI ATTRAVERSO LA CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO E DI DOCUMENTARLO.
1 Rifiuto costante di sottoporsi alle valutazioni (NC se la mancanza di valutazioni è dovuta a cause di forza maggiore).
2 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate da assenza di impegno e talvolta dal rifiuto di sottoporsi alla valutazione. Ancara scarsa l'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
3 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate da assenza di impegno e di progressi rispetto alla situazione iniziale. Ancora carente l'autonomia del metodo di studio e di organizazione del lavoro.
4 Gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate però da assiduità di impegno e dalla volontà di recuperare che hanno portato a miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
oppure
Lacune diffuse nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate da scarso impegno che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
5 Lacune non gravi ma diffuse nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate però da un impegno costante che ha portato a miglioramenti evidenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
Oppure
Lacune non gravi nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso ma accompagnate da scarso impegno che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
6 Lacune non gravi nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze fondamentali previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnate da costante impegno che ha portato a miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
Oppure
Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi a conoscenze, abilità e competenze previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnato però da un impegno saltuario che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
7 Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi a conoscenze, abilità e competenze previste dagli obiettivi per l’anno in corso accompagnato però da un impegno costante che ha portato a miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
Oppure
Raggiungimento della maggior parte degli obiettivi previsti per l’anno in corso in termini di conoscenze, abilità e competenze accompagnato da un impegno non sempre costante che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
8 Raggiungimento della maggior parte degli obiettivi previsti per l’anno in corso in termini di conoscenze, abilità e competenze accompagnato da un impegno costante che ha portato a miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
Oppure
Raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso non sempre però accompagnato da un impegno costante che ha determinato limitati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
9 Raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno costante con possibili margini di ulteriore miglioramento rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
Oppure
Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno non sempre costante che ha portato miglioramenti non sempre significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
10 Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno in corso accompagnato da un impegno costante e dalla partecipazione assidua alle lezioni che ha portato a miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza relativa sia ai risultati sia all'autonomia del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
13. Modalità di valutazione
Le fasi e le modalità per l’attribuzione della valutazione disciplinare sono:
-
Rilevazione della situazione iniziale (valutazione diagnostica): accertamento, da parte del docente, delle conoscenze e delle abilità degli studenti, indispensabili per affrontare un nuovo argomento; per le classi iniziali dei cicli si prevedono test strutturati per materia o per area disciplinare al fine di individuare il livello di preparazione e il possesso dei prerequisiti necessari per l’avvio del percorso scolastico; per le classi intermedie si prevede un periodo di ripasso cui seguirà una verifica strutturata o non strutturata.
-
Verifica e valutazione in itinere (valutazione formativa): accertamento, durante il lavoro stesso, del modo in cui procede l'apprendimento per sviluppare nello studente la capacità di autovalutarsi considerando l'errore non attribuibile a mancanza di impegno o di studio un possibile elemento utile del processo formativo; tale valutazione ha un valore fondamentale per il docente stesso in funzione anche di eventuali attività di recupero finalizzate a colmare le lacune evidenziate; ogni insegnante per poter formulare periodicamente le proprie valutazioni effettuerà verifiche di diverse tipologie specificate nella programmazione disciplinare in quantità pari o superiore a quella indicata dal Consiglio di classe nella programmazione di classe. Gli esiti delle varie prove dovranno essere tempestivamente comunicati allo studente. Inoltre, compatibilmente con il calendario delle lezioni e la quantità di ore assegnate a ciascuna disciplina, dovrà essere offerta la possibilità di recuperare le prove insufficienti entro la data prevista per il termine delle lezioni per ciascun quadrimestre/trimestre o nel quadrimestre/trimestre successivo. Nella programmazione del Consiglio di classe verranno indicati i criteri e le modalità per il recupero. Ogni docente indicherà nella propria programmazione le modalità per il recupero e l’approfondimento e quelle per la valutazione delle prove di recupero in relazione al periodo in cui verranno effettuate e alle specificità della propria disciplina sulla base dei criteri stabiliti nella programmazione del consiglio di classe. I compiti in classe dovranno essere riconsegnati corretti entro quindici giorni dalla loro effettuazione. La quantità inadeguata di valutazioni deve essere motivata. Ciascun docente dovrà specificare in sede di scrutinio nel caso di assenze prolungate se le verifiche effettuate sono sufficienti per valutare lo studente in relazione agli obiettivi fissati per la classe.
-
Valutazione sommativa periodica (valutazione sommativa): accertamento delle conoscenze degli studenti e delle loro capacità di utilizzarle in modo appropriato, al termine di un periodo didattico (quadrimestre o trimestre); tale valutazione, che avviene alla fine del percorso indicato in precedenza, è poi tradotta nella proposta di voto al termine di ciascun periodo didattico deliberato dal Collegio dei docenti e dalla delibera di attribuzione del voto da parte del Consiglio di Classe. Il voto finale proposto dal docente non scaturirà dalla media dei voti riportati nelle verifiche ma anche dall’osservazione e dalla documentazione dell’andamento del processo di apprendimento di cui le singole verifiche sono parte fondamentale ma non esclusiva.
- conoscenze (argomenti, concetti, informazioni), abilità e competenze che dovranno essere acquisite alla fine di ciascun periodo;
- obiettivi minimi richiesti per una valutazione sufficiente;
- eventuali obiettivi personalizzati per studenti disabili;
- criteri di valutazione utilizzati nelle prove di verifica.
14. Indicazioni, modalità e criteri per gli strumenti di verifica e valutazione
TIPOLOGIA DI PROVE
Verifiche scritte: verranno effettuate prove conformi alle tipologie d'esame e verranno proposte simulazioni di prima e seconda prova; in particolare, per Italiano, potrà essere effettuata una simulazione comune a tutte le classi quinte dell'Istituto.
Verifiche orali: verranno utilizzati colloqui tradizionali, test, questionari ed interrogazioni brevi con domande, poste anche in giorni diversi, che daranno luogo, sommativamente, ad una valutazione.
Verranno inoltre proposte prove grafiche e pratiche sia individuali che di gruppo.
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO
Sono state effettuate, per ogni quadrimestre, almeno quattro prove (di norma due verifiche scritte e due verifiche orali) per le materie che prevedono un insegnamento di quattro o più ore settimanali; almeno due-tre prove per quelle che hanno un numero di ore inferiori.
15. Simulazione della prima prova
Ad ogni prova sono state assegnate 6 ore.
Copie di simulazione e relative le griglie di valutazione sono reperibili in allegato.
16. Simulazione della seconda prova
Ad ogni prova sono state assegnate 6 ore.
Copie di simulazione e relative le griglie di valutazione sono reperibili in allegato.
17. Simulazione del colloquio
18. Relazione del docente di Lingua e letteratura Italiana
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Modulo 1
Il Positivismo: caratteri generali.
Il Realismo: caratteri generali
Il Naturalismo francese, E. Zola “L’Assommoir” : "L'alcol inonda Parigi".
Il Verismo. G. Verga: la vita; la formazione culturale; l'adesione al Verismo; le tecniche narrative di impersonalità e regressione; l'ideale dell'"ostrica"
Da "Vita dei campi" : Prefazione a "L'amante di Gramigna"; "Fantasticheria", "Rosso Malpelo"
Da "Novelle rusticane": "La roba".
"Il ciclo dei vinti" : caratteri generali. "I Malavoglia": contenuto, temi, sistema dei personaggi, lingua. Prefazione a "I Malavoglia"; Lettura di passi del romanzo.
“Mastro don Gesualdo” trama; lettura de “La morte di Mastro don Gesualdo”.
La Scapigliatura: caratteri generali. Tarchetti "Fosca":caratteri generali; lettura de "L'amore distruttivo"
Modulo 2
Il Decadentismo: caratteri generali. Il Simbolismo
C. Baudelaire: lettura e analisi di "Corrispondenze"; "Spleen"; "L'albatro"
Paul Verlaine: lettura de "L'arte poetica"
J.K.Huysmans: da "Controcorrente" lettura di "Una vita artificiale"
Oscar Wilde: "Il ritratto di Dorian Gray" trama e temi
G. D'Annunzio: la vita; la formazione culturale; le varie fasi della produzione dannunziana; la poetica; l’estetismo,;il panismo; il mito del superuomo.
Da “Alcyone”: "La pioggia nel pineto". “La sera fiesolana”
"Il piacere" : caratteri generali, trama, lettura de "Il ritratto di uin esteta”
“Il trionfo della morte”
"Le vergini delle rocce": il romanzo del superuomo
Modulo 3
G. Pascoli: la vita; la formazione culturale; la poetica; i temi della poesia pascoliana; il linguaggio poetico.
Da “Myricae”: "X agosto"; "Novembre"; "Temporale"; "Il Lampo"; "Il tuono"
Da Poemetti: "Italy": caratteri generali; lettura di "Italy"
Da “I Canti di Castelvecchio”: lettura e analisi de "La mia sera"
“ La grande proletaria si è mossa” caratteri generali; "Il fanciullino": contenuto; lettura di "È dentro di noi un fanciullino"
Modulo 4
La poesia del Novecento. Crepuscolari e Vociani: caratteri generali.
Futuristi: caratteri generali delle Avanguardie storiche. I "Manifesti": cenni.
I. Svevo: la vita;la formazione culturale; la poetica; i personaggi.
I primi romanzi: "Una vita" e "Senilità": caratteri generali, trama.
"La coscienza di Zeno": struttura, contenuto, temi. Lettura dei brani: "Prefazione e preambolo"; "L'ultima sigaretta"; "Una catastrofe inaudita"
Modulo 5
L. Pirandello:la vita; la formazione culturale; le opere; il vitalismo e la crisi dell'identità; la poetica dell'umorismo; i temi; il teatro.
Da “L’umorismo”: "Il sentimento del contrario"
Da "Novelle per un anno": "La patente"; "Il treno ha fischiato”;”Ciaula scopre la luna”
I romanzi: "Il fu Mattia Pascal": struttura, contenuto, temi, stile, personaggi; "Il buco nel cielo di carta"; "La lanterninosofia"
“Uno, nessuno e centomila” contenuti e trama.
Il teatro pirandelliano: metateatro e innovazioni:
“Sei personaggi in cerca d’autore” trama e caratteri generali
"Enrico IV" trama e contenuti generali
Modulo 6
G. Ungaretti:la vita; la formazione culturale; la poetica; le diverse fasi della sua produzione poetica
Da "L'Allegria": "Veglia"; "Il porto sepolto"; "Fratelli"; "Sono una creatura"; "I fiumi"; "San Martino del Carso"; "Soldati"
Da "Sentimento del tempo": "Di luglio"
Da "Il dolore": "Non gridate più"
Modulo 7
Novecentismo e Antinovecentismo. Ermetismo e S. Quasimodo: "Ed è subito sera", "Alle fronde dei salici".
(da completare nel mese di maggio)
Modulo 8
E. Montale: la vita; la formazione culturale; i temi; la poetica
Da "Ossi di seppia": "I limoni"; "Meriggiare pallido e assorto";" Non chiederci la parola"; "Spesso il male di vivere ho incontrato"
Da "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto"; "La casa dei doganieri"
Da "Satura":" Ho sceso, dandoti il braccio"
(da completare nel mese di maggio)
Modulo 9
Il Neorealismo e narrativa del secondo dopoguerra: caratteri generali: modelli; tendenze
Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”
Primo Levi “Se questo è un uomo”
Modulo 10 La scrittura. Le tipologie previste dall'Esame di Stato.
B) Strumenti didattici e materiali
Le attività sono state condotte alternando momenti di lezione frontale, dialogata,visione di filmati, apprendimento cooperativo, guida allo studio e laboratori di scrittura per la preparazione all'Esame di Stato.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
- colloqui brevi e lunghi
- prove scritte strutturate e semistrutturate all'occorrenza valide come prova orale
- prove scritte su modello della prima prova d'esame
- simulazioni di prove d'esame
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO:
nel trimestre almeno tre prove; nel pentamestre almeno quattro prove.
D) Obiettivi specifici
E) Iniziative di recupero
- sono stati predisposti momenti di potenziamento e recupero in classe durante le lezioni curricolari;
- Di fronte alla verifica di difficoltà diffuse, è stata operata una revisione della programmazione e un rallentamento nello svolgimento del programma;
- Sono stati stimolati gli alunni a frequentare le attività di studio assistito pomeridiano per la preparazione al colloquio d'esame;
- nello svolgimento dei compiti a casa, gli alunni sono stati invitati ad interagire con i docenti attraverso gli strumenti multimediali messi a disposizione.
F) Iniziative per l'approfondimento
A) APPROFONDIMENTO
Gli alunni sono stati stimolati all'approfondimento di alcuni argomenti attraverso letture mirate, visione di documentari storici e/o film e la partecipazione ai progetti proposti dalla scuola: Readings letterari Calvino e Primo Levi; Conferenza sugli Imi
B) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
G) Attività integrative
visite guidate sul territorio
partecipazione a conferenze programmate dall'Istituto in ambito storico-letterario, tecnico-scientifico ecc.;
partecipazione ai progetti d'Istituto ed alle attività di orientamento;
partecipazione ad esposizioni di settore e/o spettacoli teatrali e conferenze;
viaggio d'istruzione a Trieste , Gorizia e Lubiana.
H) Progetti
Concorso di poesia – Giornata mondiale della poesia Unesco 2024.
"La legalità come vantaggio":educare al rispetto delle regole per la costruzione del bene comune
Studio pomeridiano assistito
Memoria e memorie: IMI – Un’altra Resistenza
Biblioteca scolastica
Reading letterario ItaloCalvino
Reading letterario Primo Levi
Cerimonia di consegna dei diplomi
L) Obiettivi minimi
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
19. Relazione del docente di Storia
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Modulo 0 (di raccordo). L'alba del mondo contemporaneo. La seconda rivoluzione industriale
L'Italia tra mutamenti e crisi. La Sinistra al governo; la politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista; la politica estera della Sinistra; dal governo Crispi alla crisi di fine secolo.
Modulo 1. L'età giolittiana. Crescita economica e società di massa; la Belle époque e le sue inquietudini; le riforme sociali e lo sviluppo economico; la politica interna tra socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la caduta di Giolitti.
Modulo 2. La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto; l'Italia dalla neutralità alla guerra; le fasi della guerra; i trattati di pace.
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. Le rivoluzioni del 1917; dallo Stato sovietico all'Urss; la costruzione dello Stato totalitario di Stalin; il terrore staliniano e i gulag.
Modulo 3. Dopo la guerra: sviluppo e crisi. Crisi e ricostruzione economica; trasformazioni sociali e ideologie; la crisi del '29 e il New Deal.
Modulo 4. L'Italia dal dopoguerra al fascismo. Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; la crisi dello Stato liberale; l'ascesa del fascismo; la costruzione dello Stato fascista; la politica sociale ed economica; la politica estera e le leggi razziali. La guerra civile spagnola.
Modulo 5. La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. La repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la costruzione dello Stato totalitario; l'ideologia nazista e l'antisemitismo; l'aggressiva politica estera di Hitler.
Modulo 6. La seconda guerra mondiale. La guerra lampo; la svolta del 1941; la controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; lo sterminio degli Ebrei.
Modulo 7. Usa-Urss: la guerra fredda. Caratteri generali.
Modulo 9. L'Italia repubblicana. La ricostruzione economica; lo scenario politico del dopoguerra; gli anni dal centrismo al centro-sinistra; il “miracolo economico” (da completare nel mese di maggio)
Modulo 10. Cittadinanza e Costituzione. Si rimanda alla programmazione di ed.civica in allegato
B) Strumenti didattici e materiali
Le attività sono state condotte alternando momenti di lezione frontale, dialogata,visione di filmati, apprendimento cooperativo, guida allo studio e simulazioni del colloquio orale per la preparazione all'Esame di Stato.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
- colloqui brevi e lunghi
- prove scritte strutturate e semistrutturate all'occorrenza valide come prova orale
- prove su modello del colloquio d'esame
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO:
nel trimestre almeno tre prove; nel pentamestre almeno quattro prove.
D) Obiettivi specifici
Consolidare la distinzione tra fatti e ipotesi.
Potenziare l'individuazione dei nessi causa-effetto nelle varie sequenze.
Saper utilizzare propriamente il lessico specifico delle scienze storico-sociali.
Saper padroneggiare gli strumenti fondamentali del lavoro storico e potenziare l'analisi sui documenti storiografici.
E) Iniziative di recupero
- sono stati predisposti momenti di potenziamento e recupero in classe durante le lezioni curricolari;
- a causa di difficoltà diffuse, si è reso necessari rivedere la programmazione e un rallentamento nello svolgimento del programma;
- sono statistimolati gli alunni a frequentare le attività di studio pomeridiano attivate dalla scuola;
- nello svolgimento dei compiti a casa, gli alunni hanno potuto interagire con i docenti attraverso le stanze dei docenti.
F) Iniziative per l'approfondimento
A) APPROFONDIMENTO
Gli alunni sono stati stimolati all'approfondimento di alcuni argomenti attraverso letture mirate, visione di documentari storici e/o film, esercizi.
B) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
G) Attività integrative
visite guidate sul territorio e comunque qualsiasi offerta culturale che provenga dal territorio stesso (regione e zone limitrofe), purchè coerenti con il progetto educativo;
partecipazione a conferenze programmate dall'Istituto (ambito storico-letterario, tecnico-scientifico ecc.);
partecipazione della classe ai progetti d'Istituto ed alle attività di orientamento;
partecipazione ad esposizioni di settore e/o spettacoli teatrali e conferenze;
viaggio d'istruzione a Trieste ,Gorizia e Lubiana.
Per quanto riguarda eventuali attività alternative all'IRC il CdC ha proposto: studio autonomo
H) Progetti
"La legalità come vantaggio":educare al rispetto delle regole per la costruzione del bene comune
Studio pomeridiano assistito
Memoria e memorie: IMI – Un’altra Resistenza
Biblioteca scolastica
Reading letterario ItaloCalvino
Reading letterario Primo Levi
Cerimonia di consegna dei diplomi
L) Obiettivi minimi
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
20. Relazione del docente di Lingua Inglese
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Modulo 3 – Computers and automation
- Leibniz e l’aritmetica binaria, il codice binario (pagg. 58, 59)
- La programmazione informatica (pagg. 62, 63)
- L’organetto a cilindro per capire il sistema dei codici (pagg.66, 67)
- Dal controllo numerico (NC) al controllo numerico computerizzato (CNC) (pag.68)
- Breve storia del CNC (pag. 69)
- I droni e i loro possibili utilizzi (pag. 71, 72)
- Cos’è e come funziona il codice a barre (pag. 73)
Modulo 5 – Heat engines
- I geyser e l’energia geotermica (pagg. 102, 103)
- I motori a reazione (pagg. 104, 105, 106, 107)
- Come funzionano le pompe di calore (pag. 108)
- Le pompe e le turbine ad acqua (pag. 109)
- La pompa a vapore atmosferica di Newcomen (pag. 115)
Modulo 6 – Motor vehicles
- Come costruire una macchina di cartone (pagg. 120, 121, testo visto per studiare il lessico)
- Come funziona il motore della macchina e i suoi componenti (pagg. 122, 123, 124, 125, 126)
- I diversi tipi di tagliaerba (pag. 127)
- Le macchine ibride (pag. 129, 130)
- Il futuro delle macchine ibride (pag. 131)
- Le motociclette (pagg.132, 133, 134, 135)
- Rudolph Diesel e il motore Diesel (pagg. 136, 137)
- I trattori, come funzionano e i loro componenti (pag. 139)
Modulo 9 – CAD & CAM
- Introduzione ai termini CAE, CAD e CAM (pagg. 186, 187)
- I vantaggi dell’uso di CAD e le sue applicazioni (pagg. 189, 190
- Breve storia di AutoCAD (pag. 191)
- Le stampanti 3D (pagg. 192, 193)
- L’uso delle stampanti 3D nelle aziende produttrici di giocattoli (pagg. 194, 195)
- Altri usi della stampante 3D (pagg. 196, 197)
- Breve storia di CAD (pagg. 199)
- I pannelli isolanti strutturali (pag. 201)
Modulo 10 - Production (solo definizioni/argomenti trattati in classe)
- The Cottage Industry e la Rivoluzione Industriale (pag. 204)
- Henry Ford (pag. 209)
- Taylor e il Taylorismo (pag. 211)
- TPS - il sistema di produzione della Toyota (pagg. 215, 216)
- I sistemi di produzione moderni (pag. 217)
- L'azienda Ferrari, breve storia (pag. 144)
Educazione civica
Modulo trimestre
Human rights, Brexit and EU, the Commonwealth
Modulo pentamestre
Understanding the media: hot and cold media
B) Strumenti didattici e materiali
E' stato utilizzato il manuale Mechanix di Giovanna Battistini (Trinity Whitebridge),corredato da sintesi, mappe , video, link con materiale di supporto e di approfondimento selezionati dall'insegnante.
Le attività sono state condotte alternando momenti di lezione frontale, dialogata,visione di filmati, apprendimento cooperativo e guida allo studio per la preparazione all'Esame di Stato.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:
- prove strutturate e semistrutturate
- test o prove a scelta multipla
- produzione di brevi testi (email, descrizioni...)
- domande a risposta aperta integrative o sostitutive di interrogazioni orali
- interrogazioni lunghe e brevi
- risoluzione di esercizi
- prove di ascolto
- regolare esecuzione dei compiti assegnati
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO:
- nel trimestre almeno due prove
- nel pentamestre almeno tre prove
D) Obiettivi specifici
Alla fine del quinto anno l’alunno conosce:
• l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, con particolare riferimento a quelle
tecnico- professionali
• le modalità di produzione di testi con l’ausilio di mezzi informatici in rete
• le strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e lavoro
• le strategie di comprensione di testi tecnici e di carattere socioculturale
• le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso professionali
• il lessico e la fraseologia di indirizzo
• le modalità e i problemi di base della traduzione di testi tecnici dall’inglese e/o dal francese in italiano
Competenze e Abilità
Alla fine del quinto l’alunno è in grado di:
• esprimere e argomentare le proprie opinioni
• utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale a seconda dei contesti
• comprendere i punti principali e i dettagli di un testo in lingua standard relativi ad argomenti di studio,
lavoro e professionale
• utilizzare le principali tipologie testuali con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
• produrre relazioni scritte e orali, coerenti e coese
• redigere e comprendere brevi relazioni tecniche, eventualmente, anche su semplici esperienze
laboratoriali
• utilizzare il lessico di settore compresa la nomenclatura riconosciuta a livelli internazionale
• trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese e in francese
E) Iniziative di recupero
- rallentamenti in alcune fasi della programmazione e svolgimento di attività di recupero in itinere;
- disponibilità verso esigenze individuali;
- utilizzo della stanza del docente sul sito e/o classroom per fornire agli studenti materiali didattici, chiarimenti e mantenere un dialogo costante, che possano essere di supporto agli studenti nello studio autonomo.
F) Iniziative per l'approfondimento
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
- l’organizzazione di base del discorso nelle principali tipologie testuali, con particolare riferimento a quelle tecnico- professionali
- alcune modalità di produzione di testi con l’ausilio di mezzi informatici in rete
- semplici strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e lavoro
- strategie di comprensione di testi tecnici e di carattere socio- culturale non particolarmente complessi
- alcune strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso professionali
- il lessico e la fraseologia di base di indirizzo
- semplici problematiche di base della traduzione di testi tecnici dall’inglese in italiano
- esprimere e argomentare le proprie opinioni in modo semplice
- utilizzare alcune strategie nell’interazione e nell’esposizione orale a seconda dei contesti
- comprendere i punti principali di un testo in lingua standard relativi ad argomenti di studio, lavoro e professionale
- utilizzare alcune tipologie testuali con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
- produrre testi scritti e orali, non particolarmente complessi e sufficientemente coerenti e coesi
- utilizzare in modo sufficientemente corretto il lessico di settore compresa parte della nomenclatura riconosciuta a livello internazionale
- trasporre in lingua italiana brevissimi testi semplici scritti in inglese
Obiettivi minimi relativi alla micro lingua
Libro di testo: "Mechanix" - (G.Battistini) – Trinity Whitebridge
Modulo 3
Contenuti: Codice binario, programmazione informatica, l’uso dei droni, il codice a barre. Lessico relativo alle tematiche affrontate nel modulo 3.
Obiettivi: Saper dare una definizione semplice di codice binario e di programmazione informatica, sapere parlare in modo semplice dei droni e del loro uso, saper spiegare cos’è un codice a barre.
Modulo 5
Contenuti: Differenza tra motore a benzina e motore a reazione. Lessico relativo alla tematica.
Obiettivi: Saper parlare in modo semplice di motore a benzina e a reazione.
Modulo 6
Contenuti: Veicoli a motore, come funziona il motore di una macchina. Lessico relativo ai motori.
Obiettivi: Saper parlare dei veicoli a motore e di come funziona il motore di una macchina a livello base.
Modulo 9
Contenuti: CAD e CAM.
Obiettivi: Sapere spiegare in modo semplice l’uso del CAD e CAM.
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
21. Relazione del docente di Matematica
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
I moduli individuati dal Dipartimento per il V (e IV) anno, svolti nel corso dell'anno scolastico sono stati:
40 Le funzioni. Funzione reale di variabile reale. Dominio. Proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente, decrescente). Funzioni composte. Zeri e segno di funzione. Concetto di limite. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate (solo le prime 3). Funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti verticali. Asintoti orizzontali ed obliqui. Utilizzo dei parametri nella continuità.
41 Le derivate. La derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di funzioni composte e di funzione. Derivate di ordine superiore. Retta tangente al grafico di una funzione. Massimi, minimi e flessi. Problemi di ottimizzazione.
42 Il grafico di funzione. Grafico di una funzione e grafico della sua derivata.
43 Integrali indefiniti. L’integrale di una funzione. Significato geometrico dell'integrale. Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzione composta. Intergrazione per sostituzione, per parti e di alcune funzioni razionali fratte.
44 Integrali definiti L’integrale definito. Relazione fra integrale definitio ed aree. Area di figure curvilinee. Volumi di solidi di rotazione. Volumi con il metodo delle sezioni. Integrali definiti e parametri.
Nota: La docente si riserva, negli ultimi giorni di scuola, di fare un breve cenno al modulo 33: "Calcolo delle probabilità".
B) Strumenti didattici e materiali
- lezioni in aula frontali;
- discussioni partecipate;
- ricerche su argomenti matematici proposti;
In classe, mediante l'utilizzo della Smart TV, è stato utilizzato il software Geogebra, la Jambord di Gsuite per le spiegazione di alcuni nuovi argomenti e la correzione di alcuni esercizi, il libro digitale; la maggiorparte delle attività su Jambord sono state salvate in file PDF e condivisi su Classroom, così come i testi e le correzioni di tutte le verifiche scritte svolte in classe.
I materiali didattici utilizzati sono stati:
- libro di testo in versione cartacea e digitale;
- Jambord con creazione di appunti in PDF condivisi dal docente su Classroom;
- software di geometria dinamica "Geogebra";
- Google Documenti e Google Fogli di Gsuite.
La piattaforma Gsuite è stata utilizzata nell'attività didattica per la condivisione di documenti, materiale di supporto allo studio e la produzione di elaborati su Classroom.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
- colloqui brevi e lunghi
- prove scritte strutturate e semistrutturate all'occorrenza valide come prova orale
- esercizi e problemi
- simulazioni di prova orale d'esame
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO:
nel trimestre almeno due prove; nel pentamestre almeno tre prove.
D) Obiettivi specifici
1) saper determinare il dominio delle principali funzioni algebriche e trascendenti (goniometriche, esponenziali, logaritmiche);
2) saper calcolare i vari tipi di limite, utilizzando le strategie opportune, superando le forme indeterminate e dandone un'interpretazione grafica;
3) saper riconoscere una funzione continua e classificare i punti di discontinuità;
4) saper calcolare le derivate di funzioni di ogni tipo (tranne le inverse);
5) saper mettere in relazione i grafici di una funzione con quelli della derivata;
6) saper impostare e risolvere un problema di ottimizzazione;
7) saper calcolare gli integrali indefiniti e definiti utilizzando le tecniche opportune;
8) saper calcolare l'area di una figura curvilinea ed il volume di un solido di rotazione o di un solido con il metodo delle sezioni.
E) Iniziative di recupero
- attività di recupero in orario curricolare;
- attività di sportello pomeridiano;
- utilizzo della Google Classroom come archivio di tutto il materiale prodotto in classe (appunti, esercizi svolti, esercizi per il recupero, ecc.)
F) Iniziative per l'approfondimento
G) Attività integrative
H) Progetti
Consegna dei Diplomi
L) Obiettivi minimi
Gli obiettivi minimi rispetto ad ogni modulo individuati dal Dipartimento sono:
|
40 |
Le funzioni. |
Saper determinare il campo di esistenza di una funzione continua. Saper individuare il segno di una funzione. Saper calcolare semplici limiti. |
|
41 |
Le derivate. |
Saper calcolare la derivata prima e seconda di una funzione. Saper determinare e riconoscere un punto di massimo e/o di minimo e/o di flesso di una funzione. |
|
42 |
Il grafico di una funzione. |
Saper calcolare i limiti e gli eventuali punti notevoli di una funzione. Saper calcolare gli eventuali asintoti. Saper tracciare il grafico di una funzione. Saper dedurre dal grafico le principali caratteristiche della funzione. |
|
43 |
Integrali indefiniti |
Saper calcolare l’integrale di una funzione. Saper applicare l’integrazione per parti e per sostituzione. |
|
44 |
Integrali definiti |
Conoscere il significato geometrico dell’integrale. Saper calcolare l’area di figure curvilinee. Saper calcolare il volume di solidi di rotazione e di solidi con il metodo delle sezioni |
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
22. Relazione del docente di Meccanica, macchine ed energia
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Modulo 1 Dimensionamento di organi meccanici
ruote dentate (cilindriche a denti diritti, cilindriche elicoidali)
riduttori a uno o più stadi
alberi e assi, cuscinetti di strisciamento e di rotolamento, chiavette, linguette, profili scanalati,
giunti di trasmissione
frizioni piane e coniche
meccanismo biella -manovella
macchine di sollevamento
molle (ancora da svogere alla data corrente)
volani (ancora da svolgere alla data corrente)
vite senza fine-ruota elicoidale (ancora da svolgere alla data corrente)
Modulo 2 Elementi di macchine termiche e idrauliche
Richiami di idraulica e pompe a pistoni
B) Strumenti didattici e materiali
Lezione frontale e dialogata
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
TIPOLOGIA DI PROVE
Le verifiche sono state essenzialmente scritte.
Sono state effettuate due simulazioni della prova d'esame.
D) Obiettivi specifici
E) Iniziative di recupero
F) Iniziative per l'approfondimento
A) APPROFONDIMENTO
Non è stato possibile definire attività di approfondimento, dato lo sviluppo enorme del programma obbligatorio e la necessità di riprendere alcuni argomenti svolti negli anni precedenti che risultano indispensabili per affontare l'esame di stato
B) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
Non è stato possibile svolgere attività laboratorial, data la mole di programma da svolgere..
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
|
Conoscenze |
Abilità |
Competenze |
|
|
Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei calcoli di dimensionamento e di verifica di organi di macchine e di meccanismi.
Essere in grado di consultare ed interpretare manuali e la documentazione tecnica del settore.
Saper lavorare in gruppo |
|
|
Consapevolezza dell’effetto sull’ambiente dell’utilizzo dei combustibili fossili.
Analizzare i meccanismi di scambio dell’energia nel motore endotermico alternativo |
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
23. Relazione del docente di Sistemi e automazione
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
alimentazione, unità centrale (CPU, memoria e System Bus), unità di comunicazione, unità ingressi/uscite (moduli
d'ingresso digitali,moduli d'uscita digitali, moduli d'ingresso analogici,moduli d'uscita analogici,moduli I/O remoti, moduli
specializzati), terminale di programmazione (classificazione dei terminali di programmazione e programmazione con PC).
Funzionamento del PLC: elementi funzionali (elementi funzionali logici ed elementi funzionali matematico/logici),
indirizzamento degli elementi funzionali e degli I/O.
MODULO 2: Programmazione di un PLC: I linguaggi di programmazione: linee guida della normativa IEC EN 61131 –
3, linguaggi grafici, linguaggi letterali. Le fasi della programmazione del PLC (definizione dello schema
funzionale, indirizzamento degli elementi funzionali, codifica, implementazione del programma) con riferimento al PLC virtuale proposto dal libro di testo.
Il linguaggio LD e la conversione del diagramma a relè in linguaggio a contatti (LD), istruzioni fondamentali di logica a relè.
MODULO 3: Trasduttori: Nozioni generali: definizioni, classificazione, parametri caratteristici.
Funzionamento dei trasduttori: trasduttori di posizione (potenziometri lineari e angolari, riga ottica,trasformatore
differenziale, inductosyn, resolver, syncro resolver ed encoder) trasduttori di velocità (dinamo tachimetrica ed alternatore
tachimetrico), trasduttore di forza (estensimetri a resistenza ed estensimetri piezoelettrici), trasduttori di pressione
(trasduttori estensimetrici e trasduttori potenziometrici), trasduttori di livello (trasduttori conduttivi, capacitivi ,
trasduttori a tasteggio elettromeccanico, trasduttori a ultrasuoni, trasduttori a microonde e
trasduttori a pressione idrostatica) trasduttori di flusso (trasduttori di flusso magneto-induttivi, flussostati a vortice,
trasduttori di flusso a ultrasuoni, flussostati a microonde e flussostati a scambio calorimetrico), trasduttori di temperatura
(termoresistenze, termistori, termocoppie e trasduttori di temperatura integrati) e trasduttori di prossimità (interrutori
induttivi, interrutori capacitivi, trasduttori a ultrasuoni, sensori a effetto Hall e fotocellule).
B) Strumenti didattici e materiali
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
Come strumenti di valutazione sono state utilizzate prove orali, scritte (talvolta strutturate) e pratiche; le verifiche corrette sono state riconsegnate non oltre 15 giorni dalla data di effettuazione.
E' stato rispettato il numero minimo di prove per periodo scolastico: 2 verifiche scritte, orali per il primo periodo e 3 per il secondo.
D) Obiettivi specifici
E) Iniziative di recupero
F) Iniziative per l'approfondimento
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
|
Conoscenze |
Abilità |
Competenze |
|
Il Sistema PLC · Il sistema PLC: logica cablata e programmabile, classificazione e architettura del PLC, unità di alimentazione, unità centrale, unità di comunicazione, unità ingressi/uscite, terminale di programmazione, strumenti di supervisione, sicurezza dei sistemi di controllo con PLC · Funzionamento del PLC: elementi funzionali, indirizzamento degli elementi funzionali e degli i/o |
· Identificare i principali vantaggi della logica programmabile rispetto a quella cablata · Conoscere le principali funzioni svolte dai dispositivi che costituiscono il PLC |
· Valutare la convenienza del ricorso alla logica programmabile nel contesto dello studio di fattibilità di un sistema di automazione |
|
Programmazione di un PLC · I linguaggi di programmazione: linee guida della normativa IEC EN 61131 – 3, linguaggi grafici, linguaggi letterali, le fasi della programmazione del PLC, il PLC virtuale proposto dal libro di testo · Il linguaggio LD e la conversione del diagramma a relè in linguaggio a contatti LD, istruzioni fondamentali di logica a relè. |
· Conoscere le tipologie di linguaggi di programmazione definiti dalla norma IEC EN 61131 – 3 · Identificare le varie fasi della programmazione di un PLC |
· Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC · Utilizzare semplici strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo |
|
Trasduttori · Nozioni generali: definizioni, classificazione, parametri caratteristici e criteri di scelta · Funzionamento dei trasduttori: trasduttori di posizione, velocità, forza, pressione, livello, flusso, temperatura e prossimità |
· Conoscere la classificazione, i parametri caratteristici e il funzionamento dei principali trasduttori |
· Scegliere opportunamente il tipo di trasduttore necessario a svolgere funzioni di regolazione e controllo |
|
Laboratorio · Programmazione di PLC Siemens per semplici funzioni logiche. |
· Semplici applicazioni pratiche di programmazione di un PLC. |
· Operare ed interpretare semplici applicazioni pratiche di programmazione di un PLC Siemens |
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
24. Relazione del docente di Disegno, progettazione ed organizzazione industriale
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
MODULO 1: Cinghie, funi e catene: Trasmissione con cinghie piatte: generalità, materiali e carichi di sicurezza, rapporto di trasmissione, avvolgimento della cinghia e pulegge per cinghie piatte - Trasmissioni con cinghie trapezoidali: generalità, pulegge per cinghie trapezoidali e calcolo di una trasmissione con cinghie trapezoidali - Trasmissioni con cinghie dentate: generalità, cinghie dentate e pulegge - Trasmissione con cinghie scanalate: dimensionamento di trasmissioni con cinghie Poly-V - Trasmissioni con funi metalliche: generalità, materiali, dimensionamento delle funi e pulegge per funi - Trasmissioni con catene: tipi di catene e ruote dentate per catene.
MODULO 2: Ruotismi: Ruote di frizione - Ruote dentate ed ingranaggi: generalità e definizione, rappresentazione convenzionale, proporzionamento degli ingranaggi cilindrici, minimo numero di denti, dentature ribassate, dentature corrette, controllo della dentatura, forme costruttive e rendimento, ingranaggi cilindrici a denti elicoidali ed ingranaggi conici - Ingranaggio a vite: generalità, forme costruttive e rappresentazione sui disegni - I rotismi: generalità, ruotismi con ruote oziose, ruotismi ordinari e ruotismi epicicloidali - I riduttori: generalità, materiali e lubrificazione.
MODULO 3: Organi di collegamento: Dispositivo biella manovella (generalità, biella e manovella) - Camme:generalità, tipi di camme e cenni sul tracciamento del profilo delle camme - Eccentrici – Arpionismi
MODULO 4: Tecnologie applicate alla produzione: Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico. Velocità di minimo costo. Velocità di massima produzione. Velocità di massimo profitto. Tempi e metodi nelle lavorazioni. Il tempo nella produzione. Rilevamento diretto Cronotecnica. Tempi standard. Metodo M.T.M. Abbinamento di più macchine - Generalità sulle condizioni di taglio. Macchine operatrici con moto di taglio circolare: tornitura, fresatura, foratura. Cenni sulla rettificatura, limatura, piallatura e strozzatura, bocciatura, filettatura e dentatura. Utensili da taglio
MODULO 5: Cicli di lavorazione: Generalità sui cicli di lavorazione. Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione. Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. Cartellino del ciclo di lavorazione. Foglio analisi operazione.
Modulo 6: Prodotto, Progettazione e fabbricazione: Azienda. Evoluzione storica e organizzazione industriale. Funzioni aziendali e strutture organizzative. Modelli organizzativi. Produzione snella. La contabilità generale e industriale. I costi aziendali: il costo in funzione del tempo e valore aggiunto. Relazione tra costi e produzione: costi variabili, fissi e semifissi, determinazione della retta Costo-Volume, analisi Costi-Profitti, diagramma utile-volume di produzione, punto di equilibrio BEP e considerazioni sui costi variabili. Innovazione, progettazione e fabbricazione di un prodotto. Fasi di progettazione. Scelta del processo di fabbricazione. Tipologie di automazione, scelta del livello di automazione. Piano di produzione: cosa, quando, quanto, dove, come. Tipi di produzione e di processi: in seria, a lotti, JIT. Produzione per reparti ed in linea. Saturazione della macchina. Diagramma di saturazione. Acquistare o produrre. Lotto economico per prodotto singolo, lotto economico con il tempo di attrezzaggio. Lay-out degli impianti. Elementi di ricerca operativa, problemi di sequenzialità, programmazione del lavoro. Tecniche reticolari - PERT e diagrammi di GANTT.
Modulo 7: Qualità e sicurezza : caratteri generali.
B) Strumenti didattici e materiali
Si sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo:L. Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, Dal Progetto al Prodotto Disegno meccanico e tecniche CAD e Dal Progetto al Prodotto Disegno Progettazione Organizzazione Industriale TECNICHE CAM, Paravia PEARSON (volume 2 e 3)
- Libro: L.Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, Manuale di Meccanica, Hoepli
- Appunti e fotocopie forniti dal docente.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
TIPOLOGIA DI PROVE
Come strumenti di valutazione sono state prese in considerazione tutte le possibili tipologie di prove orali, scritte e grafiche. Un aspetto importante per la valutazione è l' impegno e la partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni.
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO
Trimestre:
-minimo 3 verifiche orali/scritte/pratiche.
Pentamestre:
-minimo 4 verifiche orali/scritte/pratiche
D) Obiettivi specifici
- Far acquisire una mentalità progettuale riuscendo a compilare complessivi meccanici e sviluppando disegni esecutivi dei particolari;
- Conoscere ed utilizzare software di disegno meccanico;
- Sviluppare cicli di lavorazione e montaggio con scelte di convenienza economica;
- Avere una conoscenza della struttura dell'impresa, delle sue funzioni, della sua organizzazione con riferimento alla attività industriale;
- Conoscere i principali aspetti della organizzazione industriale in riferimento alla programmazione, avanzamento e controllo della produzione.
E) Iniziative di recupero
Lo sforzo è stato quello di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al recupero dell'interesse e dell'attenzione degli alunni in orario curricolare.
F) Iniziative per l'approfondimento
Recupero mattutino in itinere
B) APPROFONDIMENTO
Gli alunni sono stati stimolati all'approfondimento di alcuni argomenti e tematiche attraverso la visione di testi multimediali.
C) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
Si prevede l' uso delle attività laboratoriali, come momento di completamento ed approfondimento dei contenuti proposti.
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
|
Conoscenze |
Abilità |
Competenze |
|
Cinghie, funi e catene · Trasmissione con cinghie piatte, trapezoidali, dentate e scanalate · Trasmissioni con funi metalliche · Trasmissioni con catene |
· Riconoscere i diversi tipi di cinghie e catene · Individualizzare i diversi tipi di fune
|
· Realizzare trasmissioni con l’uso di cinghie
· Realizzare trasmissioni mediante catene |
|
Ruotismi · Ruote di frizione. · Ruote dentate ed ingranaggi · Ingranaggio a vite · I rotismi · I riduttori |
|
· Progettare trasmissioni con ruote di frizione · Dimensionare e disegnare ruote dentate a denti dritti, elicoidali e conici. · Progettare e disegnare un semplice riduttore di velocità |
|
Organi di trasmissione del moto · Sistema biella manovella · Camme · Eccentrici · Arpionismi |
· Definire camme ed eccentrici |
· Dimensionare e disegnare bielle e manovelle |
|
Tempi e Metodi · Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico. · Tempi e metodi nelle lavorazioni · Tempi standard · Abbinamento di più macchine |
· Costo totale di un’operazione e le singole voci di costo · Fasi di un’operazione, la durata, i tempi ed i metodi di rilevazione · Tempi standard, metodo MTM · Diagrammi di carico |
· Calcolare il costo totale di un’operazione · Calcolare la velocità di minimo costo, massima produzione e massino profitto · Calcolare le fasi un’operazione e la loro durata anche con l’uso del metodo MTM |
|
Macchine Operatrici · Generalità sulle condizioni di taglio · Macchine operatrici con moto di taglio circolare: tornitura, fresatura, foratura. Cenni sulla rettificatura, limatura, piallatura e strozzatura, bocciatura, filettatura e dentatura · Utensili da taglio. |
· Descrivere i parametri di taglio · Conoscere i principali materiali e designare gli utensili |
· Scegliere i parametri di taglio · Calcolare la potenza di taglio · Calcolare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni · Individuare i diversi tipi di utensili |
|
Cicli di lavorazione · Cicli di lavorazione · Dal disegno di progetto al disegno di fabbricazione · Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. · Cartellino del ciclo di lavorazione. · Foglio analisi operazione |
· Definire un ciclo di lavorazione · Descrivere le caratteristiche del cartellino del ciclo di lavorazione · Descrivere le caratteristiche del foglio analisi operazione · Conoscere le differenze tra il disegno di progettazione e il disegno di fabbricazione
|
· Elaborare un ciclo di lavorazione · Compilare un cartellino del ciclo di lavorazione · Stendere un foglio analisi operazione |
|
Prodotto, Progettazione e fabbricazione · Azienda: evoluzione storica e organizzazione industriale. Funzioni aziendali e strutture organizzative. Modelli organizzativi. Produzione snella. · La contabilità nelle aziende. Costi aziendali. Relazione tra costi e produzione. Centri di costo e ripartizione dei costi. · Innovazione, progettazione e fabbricazione di un prodotto. Fasi di progettazione. Scelta del processo di fabbricazione. Tipologie di automazione, scelta del livello di automazione. Piani di produzione. Tipi di produzione e di processi. Lotto economico di produzione. Lay-out degli impianti. · Elementi di ricerca operativa. Tecniche reticolari. PERT e digramma di GANTT. |
· La visione dell’azienda · Strutture organizzative aziendali · Esprimere i concetti di contabilità generale e industriale · Definire i diversi tipi di costi, l’interesse e il tasso di interesse · Definire il punto di pareggio · Tipologie di produzione e di automazione · Piani di produzione · Scelta lay-out · Carico macchine · Lotto economico di produzione · Tecniche reticolari e rappresentazione grafica della loro attuazione · Diagramma di Gantt
|
· Definire le principali strutture aziendali e individuare i modelli organizzativi · Descrivere le caratteristiche della produzione snella · Calcolare le diverse modalità di restituzione di un capitale · Rappresentare l’andamento dei costi nel tempo · Calcolare il punto di pareggio · Ripartire i costi nei centri di costo · Scegliere le tipologie di produzione · Definire il carico delle macchine e la loro saturazione · Determinare un lotto economico · Elaborare una programmazione operativa con il PERT · Costruire diagrammi di Gantt |
|
La Qualità · Generalità sulla Qualità. Termini e definizioni. Struttura del Sistema qualità. Documentazione del sistema qualità e controllo dei processi. Il controllo statistico di Qualità per variabili, per attributi, per difetti, per accettazione. Piano di campionamento. Strumenti per il miglioramento della qualità. |
· Conoscere la normativa sulla qualità · Conoscere i termini e le definizioni caratteristiche · Conoscere i principi per la gestione della qualità · I vari piani di campionamento · Gli strumenti atti a migliorare la qualità |
· Descrivere la struttura del sistema di qualità · Utilizzare la documentazione prevista · Individuare le azioni di controllo e miglioramento della qualità · Utilizzare i vari tipi di piani di campionamento · Applicare strumenti per il miglioramento della qualità nel contesto reale
|
|
Sicurezza · Principi di sicurezza, salute ed ergonomia · Fattori di rischio nell’ ambiente di lavoro · Legislazione sulla sicurezza ed enti preposti · Testo Unico sulla sicurezza, salute e prevenzione infortuni e malattie professionali · Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE |
· Conoscere i concetti fondamentali di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro · Elencare gli enti statali preposti al controllo della prevenzione e sicurezza sul lavoro · Esporre gli obblighi di carattere generale previsti per i principali soggetti addetti alla sicurezza sul lavoro · Conoscere le linee guida della Direttiva Macchine 2006/42/CE |
· Saper valutare i rischi nell’ ambiente di lavoro · Utilizzare i dispositivi di protezione individuale · Applicare la Direttiva Macchine 2006/42/CE |
|
Laboratorio · Uso di AutoCad per il disegno 2D: conoscenza dei concetti dei comandi base del software di disegno Autocad. Conoscenza approfondita degli strumenti informatici e l'utilizzo di tecniche CAD (Computer Aided Design)
|
· Utilizzare in completa autonomia un sistema CAD (Computer Aided Design) per la realizzazione, modifica e gestione di disegni e progetti, mediante l'utilizzo di sistemi di quotatura, proprietà grafiche e di presentare l’output grafico nel modo più dettagliato ed efficace.
|
|
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
25. Relazione del docente di Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
|
Modulo |
Contenuti |
Periodo |
|
1) Diagramma di equilibrio della lega Fe-C e trattamenti termici |
Diagramma di equilibrio della lega Fe-C e punti critici. |
Ott./Nov. |
|
2) Lavorazione dei materiali con metodi non convenzionali |
Lavorazione per elettroerosione a tuffo ed a filo. |
Marzo |
| 3) Comando Numerico Computerizzato |
Cenno alla struttura delle M.U. a CNC |
Dic./Feb. |
|
4) Controlli non Distruttivi (NDT) |
Principali metodi di controllo non distruttivo sui materiali e/o prodotti finiti: liquidi penetranti, esami magnetoscopici, esami radiografici, controlli con ultrasuoni. |
Aprile |
|
5) Corrosione e Protezione |
Tipi di corrosione dei materiali metallici. |
Maggio |
|
7) Cicli di lavorazione |
Esempi di cicli di lavorazione di semplici componenti: |
Apr. / Magg. |
|
Laboratorio: |
Lavorazioni alle M.U. tradizionali (tornio, fresa, trapano) |
durante a.s. |
B) Strumenti didattici e materiali
Per ogni argomento si è cercato di evidenziare come la disciplina possa affrontare i problemi progettuali partendo dalla schematizzazione di essi scomponendoli in casi elementari.
Si sono usati, prevalentemente il libro di testo, ma anche materiale didattico integrativo, i manuali tecnici facendo uso di lezioni frontali con ausilio di video, di esercitazioni in classe o in laboratorio, ed altri materiali distribuiti in forma cartacea ed anche tramite la piattaforma "Classroom".
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
TIPOLOGIA DI PROVE
Come strumenti di valutazione si sono utilizzate tutte le possibili tipologie di prove, sia orali che scritte, ma anche quelle di tipo grafico/pratiche.
Sono state proposte, inoltre, prove pratiche di lavorazione alle M.U. sia individuali che di piccolo gruppo.
NUMERO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO
Nel trimestre:
- 3 verifiche o prove (tra tutte le tipologie previste)
Nel pentamestre:
- 4 verifiche (tra tutte le tipologie previste)
ALTRE INDICAZIONI
D) Obiettivi specifici
- Progettazione, dimensionamento ed elaborazione di un ciclo di lavorazione di singoli componenti o semplici gruppi meccanici
- Controllare la diffettologia della produzione di componenti con metodi non distruttivi
- Le metodologie di protezione dei manufatti metallici degli agenti corrosivi.
- Le tecniche non convenzionali, o innovative, di lavorazione sui diversi materiali di interesse meccanico-tecnologico.
- conoscere le caratteristiche funzionali, l’impiego e l’uso delle macchine utensili A CNC
- sviluppare programmi esecutivi per macchine a C.N.C. con linguaggio ISO
E) Iniziative di recupero
Per il recupero del debito del primo periodo, si previsto il recupero in autonomia da parte dei pochi coinvolti.
Per una alunna, si sono invece dovuti dare tempi diversi per lo svolgimento delle prove valutative, spesso non effettuate per assenza.
F) Iniziative per l'approfondimento
A) APPROFONDIMENTO
Sono state utilizzate visite guidate a manifestazioni di "settore".
B) USO DEI LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE
Le attività laboratoriali hanno affiancato, e completato, la trattazione teorica, con apprendimento pratico di alcuni moduli ed hanno previsto attività sia singole che di gruppo.
L'attuale situazione delle officine (spazi e dotazioni ridotti) non ha consentito di poter svolgere una attività laboratoriale pienamente soddisfacente e completa, in particolare per la materia in oggetto: di conseguenza si sono svolte solo quelle attività consentite e compatibili con la presente situazione logistica, organizzandole per gruppi di studenti in numero consentito dagli spazi. I gruppi si sono alternati settimanalmente nella frequentazione dei laboratori "Tecnologici".
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
- Le tecniche non convenzionali di lavorazione con le quali si asporta il truciolo sui più diversi materiali.
- Una base conoscitiva della programmazione ISO usate dalle macchine utensili a C.N.C.
- I problemi, e le possibili soluzioni, protezione, legati alla corrosione dei metalli.
- I principali metodi di controllo tramite tecniche non distruttive.
M) Attività laboratoriali
- Tornitura
- Fresatura
- Foratura
- Saldatura
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
26. Relazione del docente di Robotica
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Elementi di robotica
Modulo 1 Modellazione solida con Solidworks
Elementi base degli ambienti parte e assieme, creazioni di animazioni con Solidworks Motion.
Modulo 2 Studio del movimento nel piano e nello spazio di un robot
- Struttura del robot industriale: giunti, assi e gradi di libertà, Spazio di lavoro, capacità di carico, accuratezza, ripetibilità e velocità, polso e organi terminali del robot (end effector)
- robot cartesiani, robot cilindrici, robot sferici, robot SCARA, robot articolato (da completare al momento della redazione della presente relazione).
- Argomenti vari di cinematica del punto e del corpo rigido piano (in particolare studio cinematico del sistema biella manovella)
B) Strumenti didattici e materiali
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
D) Obiettivi specifici
E) Iniziative di recupero
F) Iniziative per l'approfondimento
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
|
Conoscenze |
Abilità |
Competenze |
|
Elementi di robotica Modulo 1 Modellazione solida con Solidworks (o altro software 3D). Elementi base dell’ambiente parte e assieme, esportazione della mesh e importazione in CoppeliaSim Modulo 2 Studio del movimento nel piano e nello spazio di un robot - Richiami sulla struttura del robot industriale (Giunti, assi e gradi di libertà, Spazio di lavoro, capacità di carico, accuratezza, ripetibilità e velocità, robot cartesiani, robot cilindrici, robot sferici, robot SCARA, robot articolato. Giunti secondari e polso, organi terminali del robot (end effector) - Argomenti vari di cinematica (studio cinematico del sistema biella manovella)
|
Saper realizzare semplici parti in ambiente 3D con il softeare Solidworks Saper realizzare semplici assiemi assemblando delle parti Saper realizzare semplici animazioni a partire dall'assieme. partire dalle parti compone Iidentificare le parti componenti il robot riconoscendone le proprietà funzionali fondamentali |
|
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
27. Relazione del docente di Scienze motorie e sportive
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
Mod. 1 pallavolo,
Mod. 2 pallacanestro,
Mod. 3 Pickleball
Mod. 5 calcio a 5
Mod. 6 atletica leggera
Primi cenni di tennis
Come argomenti orali sono stati affrontati temi riguardanti:
Il Doping, vecchi sistemi e il nuovo Doping genetico inerente alll'educazione civica
e Metodologia dell'allenamento
B) Strumenti didattici e materiali
Fotocopie
Video
Lezioni frontali / Partecipate in palestra
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
scritte, orali anche su più giorni, o pratiche.
NUMERO MINIMO DI PROVE PER PERIODO SCOLASTICO
Il numero di verifiche nel trimestre dovrà essere di almeno due prove.
Il numero di verifiche nel pentamestre sarà di almeno tre prove.
D) Obiettivi specifici
- portare il materiale
- puntualità
- partecipazione attiva
- rispetto delle regole del prossimo e delle strutture
- disponibilità a collaborare
- impegno
Cercare di affermare una certa autonomia attraverso una maggior conoscenza e consapevolezza di sé, mostrare di possedere conoscenze essenziali superficiali, fornisce risposte quasi complete.
Rispetto alle Capacità coordinative generali e speciali, alle Capacità condizionali, al Livello di padronanza dei gesti tecnici, supera l’obiettivo minimo in condizione di esecuzione facile.
E) Iniziative di recupero
- nel corso dell'anno scolastico le eventuali necessità sono state affrontate o con un lavoro individualizzato o con lezioni generali di recupero a discezione del docente;
- pubblicazione di materiale su classroom.
F) Iniziative per l'approfondimento
APPROFONDIMENTO
- sviluppo di temi ed argomenti che maggiormente interessano gli studenti per stimolarne il coinvolgimento;
- Approfondimento dell'argomento di educazione civica
G) Attività integrative
Partecipazione a tornei interni di giochi sportivi
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
- portare il materiale
- puntualità
- partecipazione attiva
- rispetto delle regole del prossimo e delle strutture
- disponibilità a collaborare
- impegno
Cercare di affermare una certa autonomia attraverso una maggior conoscenza e consapevolezza di sé, mostrare di possedere conoscenze essenziali superficiali, fornisce risposte quasi complete.
Rispetto alle Capacità coordinative generali e speciali, alle Capacità condizionali, al Livello di padronanza dei gesti tecnici, si è superato l’obiettivo minimo in condizione di esecuzione facile.
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
28. Relazione del docente di Religione Cattolica
A) Argomenti e moduli trattati (Programmi Svolti)
1) Tutte le religioni sono uguali?
2) Commenti sull'articolo: Capire dagli occhi di una nonna che l'amore esiste
3) Dalla guerra alla fede. In che senso la fede può salvare il mondo?
4) Lettera a Diogneto: i cristiani amano tutti, ma da tutti vengono perseguitati
5) I santi
6) Video: La maturità da ripetere. Spunto per parlare delle nostre forme di maturità
7) Una storia vera: visione integrale del film, e discussione, traendo spunto da alcune scene
8) In continuo movimento: essere come un turista, oppure in cerca di condizioni di vita migliori
9) Il calcio, lo sport e la società
10) Francesco: visione del film di Cavani
11) San Francesco d'Assisi ed il valore della castità
12) Umiltà. Consapevolezza dei limiti
13) Le stimmate di San Francesco, dal film di Cavani
14) Qualche riflessione, a partire dal libro Fratellino
15) Le filosofie della nascita
16) Il limite degli uomini, i punti deboli da rafforzare
17) Il matrimonio cristiano
18) Cuore sacro, visione del film
B) Strumenti didattici e materiali
Lezione dialogata, ed apprendimento in gruppi di lavoro.
C) Caratteristiche delle prove di valutazione
D) Obiettivi specifici
E) Iniziative di recupero
F) Iniziative per l'approfondimento
G) Attività integrative
H) Progetti
L) Obiettivi minimi
- Conoscere i tratti essenziali della figura di Gesù e del suo messaggio
- Cogliere il rapporto tra fede e ragione
- Conoscere i principali tratti peculiari del cattolicesimo
M) Attività laboratoriali
Massa, lì 15/05/2024 Il Docente
29 Sottoscrizione del documento
Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta del 15/05/2024, consegnato per essere affisso all'albo.
| Disciplina | Docente | Firma |
|---|---|---|
| Scienze motorie e sportive | ANGELONI AGOSTINO | |
| Religione Cattolica | ANNIBALI STEFANO | |
| Sostegno | BENEDETTI MARIA AURORA | |
| Sistemi e automazione | BETTINI LUCA | |
| Lingua Inglese | Cenderelli Alessia | |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | Cioni Paolo | |
| Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | CORDIVIOLA ALICE | |
| Storia | Corsetti Lorenza | |
| Lingua e letteratura Italiana | Corsetti Lorenza | |
| Lab. Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | GALATI ANTONINO | |
| Lab. Robotica | Lazzarotti Gabriele | |
| Lab. Sistemi e automazione | Lazzarotti Gabriele | |
| Sostegno | NAGY NORBERT IOSIF | |
| Robotica | PIACENTINI ALESSANDRO | |
| Meccanica, macchine ed energia | PIACENTINI ALESSANDRO | |
| Matematica | SIMONINI ALESSANDRA | |
| Lab. Meccanica, macchine ed energia | Tonlazzerini Luca | |
| Lab. Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | Tonlazzerini Luca |
Massa, lì 15/05/2024
Il Docente CoordinatoreIl Dirigente Scolastico
Prof. Corsetti LorenzaProf. ANTONIO GIUSA
Allegati al Documento
- Prima simulazione della Prima Prova dell'Esame di Stato
- Seconda simulazione della Prima Prova dell'Esame di Stato
- Griglie di valutazione della Prima Prova
- Griglia di valutazione seconda prova scritta
- Prima simulazione seconda prova scritta
- Seconda simulazione seconda prova scritta
- Attività PCTO
- Educazione civica 5AMEC
- Piano dell'orientamento 5AMEC 2023/24